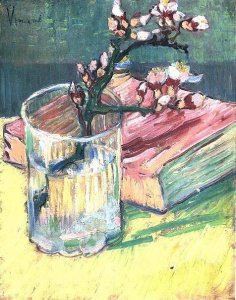13 Febbraio 2019 | Vorrei, quindi scrivo
«Una start up è come un gruppo musicale. Cerchi un batterista e qualcuno dice: ‘Ah, io andavo a scuola con uno che suonava la batteria’. A quel punto, il tuo futuro si lega a doppio filo a quello delle persone con cui ti ubriacavi al bar dell’università o giocavi dopo la scuola».Garry Tan, fondatore di un fondo di capitali di rischio, descrive così la nascita di una start up: servono un paio di amici, una bella idea, un pò di talento (e di fortuna) e i compagni del liceo diventano manager o, nell’altro caso, rockstars famose in tutto il mondo. Basta pensare all’analogia della nascita tra aziende come Microsoft e Apple e band come i Rolling Stones e i Beatles.
Ogni membro ha una propria personalità: punti di forza e debolezza devono sposarsi al meglio, in modo da costruire un rapporto equilibrato e, soprattutto, durevole nel tempo. La provocazione e il menefreghismo di Jagger, l’equilibrio e la capacità di mediazione di Harrison sono stati elementi fondamentali per costruire un gruppo, una squadra con un obiettivo comune: fare musica e spaccare il mondo.
E che dire di caratteri come quelli di Jobs o Gates? Ambiziosi, geniali e precisi, il primo arrogante, il secondo filantropo.
É quindi evidente come in una squadra ci siano equilibri che si creano e che spesso traballano e come ogni membro debba accogliere le diversità e contribuire al raggiungimento di una dinamica interna. Ovviamente l’unità e la stabilità del gruppo non sempre vengono sviluppate in maniera pari da tutti i membri: c’è sempre una personalità più forte e meno disposta alla democrazia, eppure questo disequilibrio viene spesso considerato un vantaggio: «nelle band che sopravvivono a lungo spesso si trova un accordo sul non essere d’accordo. Le persone che non si sopportano possono trovare modi interessanti per andare avanti» (Internazionale n.1289).
Ne deriva che in ogni gruppo ci sia una soglia di tensione che rappresenti un livello ottimale di conflitto, fino a quando questo non diventi incontrollato e la band si distrugge. É forse il caso degli Stones e del loro successo infinito: sono riusciti a trovare una quadratura tra le diverse personalità, non hanno mai avuto paura ad osare, nè a litigare tra loro, affrontando più apertamente i disaccordi e arrivando anche e spesso ai pugni. Al contrario, per i Beatles l’amicizia e la sincronia sono sempre stati fondamentali, erano “quattro parti di un’unità” come aveva dichiarato McCartney e Jagger li definiva «il mostro a quattro teste»: addirittura si tagliavano i capelli nello stesso modo e si completavano le frasi a vicenda durante le interviste. Questa armonia non è mai esistita negli Stones, ma il rapporto da “nemici-amici” tra loro creatosi è stato più efficiente siccome la band si esibisce tuttora sui palchi in giro per il mondo, mentre i Beatles sono fuori gioco da anni.
Pur essendo caratterialmente così diverse, entrambe le celebri band inglesi hanno raggiunto a un certo punto l’apice del successo. Tale traguardo è anche stato guadagnato grazie ad una chiara e volontaria divisione delle diverse responsabilità: una personalità come quella di Mick Jagger non poteva che incarnare il ruolo del leader.
È curioso come da un punto di vista economico il cantante, pur sapendo poco di business, sia anche stato «un brillante uomo d’affari», come lo ha definito Robert Greenfield, biografo degli Stones. La rockstar ha infatti dichiarato: «I don’t really count myself as a very sophisticated businessperson. I’m a creative artist. All I know from business I’ve picked up along the way».
É quindi più che lecito paragonare una band musicale ad una start up. Le rockstars non sono altro che i fondatori di un’azienda, che con il loro talento danno origine a delle idee, le sviluppano e trasformano il sogno di una vita in realtà. Anche senza un’adeguata esperienza o preparazione (e in molti casi senza soldi), si ritrovano catapultati dal garage in cui è nato il progetto ad un’impresa complessa, se non addirittura ad un marchio globale che genera un enorme flusso di ricavi.
Una start up, che sia più democratica o dittatoriale, deve rappresentare i valori del team, coordinare in maniera efficace le attività, garantire un fluido e corretto scambio di informazioni . Tutti i membri della squadra hanno delle responsabilità riguardo agli obiettivi ed è importante che tutti si sentano soddisfatti e motivati, in modo da non creare un ambiente noioso e apatico. Inoltre conviene concentrarsi su ciò che unisce piuttosto che su ciò che divide, dando vita ad un rapporto sano e trasparente.
Capire come un gruppo di persone diventi più della somma delle sue parti e riuscire a tenerlo insieme è fondamentale, sia per una rock band sia per un’azienda.
Bisogna avere un obiettivo comune, sforzarsi di superare i propri limiti e, a volte, riuscire a scendere a compromessi senza però mai farsi calpestare e soprattutto osare, perchè come dicono gli Stones «you can’t always get what you want, but if you try sometimes you get what you need».
3 Gennaio 2019 | Vorrei, quindi scrivo
Avete mai sentito parlare di Giorgio Perlasca? Pochi sanno chi fosse perché era un uomo estremamente modesto a cui non piaceva né apparire in televisione, né essere intervistato dai giornalisti. Enrico Deaglio scoprì la sua incredibile storia e scrisse La banalità del bene, la RAI programmò una fiction e Perlasca divenne così un personaggio pubblico. La sua storia è così straordinaria che molti l’hanno messa in dubbio. Io ve la voglio raccontare.
Giorgio Perlasca era un commerciante padovano che, quando si trovò a Budapest nell’inverno del 1944, riuscì a salvare la vita di migliaia di ebrei. Pur essendo stato in passato un fascista entusiasta, l’8 settembre 1943 dovette nascondersi nell’ambasciata spagnola a Budapest perché ricercato dalle SS in quanto italiano. Resosi conto di ciò che lo circondava, si finse console spagnolo e, decidendo di rischiare la propria vita invece che mettersi in salvo, protesse oltre 5000 persone in edifici che lui fintamente dichiarò sotto la tutela della Spagna, stato neutrale guidato da un governo filofascista per il quale aveva combattuto nella guerra civile spagnola. I nazisti, per paura di provocare un incidente diplomatico, accettarono le sue condizioni e gli permisero di dar ricovero a molti il cui destino sarebbe stato, altrimenti, il lager. La maggior parte delle persone che ospitò giunse incolume alla fine della guerra. L’incipit del libro di De Aglio è una domanda: come potè affrontare una situazione così difficile con tanta naturalezza e buona volontà. E Perlasca rispose nel modo più semplice: “Lei, che cosa avrebbe fatto al mio posto?”.
Questa domanda mi ha fatto riflettere molto: io come mi sarei comportata?
Sono una minoranza le persone che rischierebbero la propria vita per tentare di salvare quella di sconosciuti, senza garanzia alcuna né di salvare sé stessi né gli altri. Di fronte a grandi o piccoli pericoli è più facile rendersi complici del male che del bene, per ignavia o per semplice paura. Non tutti hanno l’animo dell’eroe. Eppure non obbligatoriamente l’atto eroico deve avere le caratteristiche del mito. L’eroismo spesso si manifesta con il compiere azioni abituali che rispondono però a una morale di fraternità. Perlasca ebbe l’intuizione, il coraggio e la capacità di compiere l’azione giusta, pericolosa e rischiosa che però cambiò la sorte di molte vite innocenti, strappandole ai “treni della morte”.
Raccontare questa storia porta ad una profonda riflessione interiore, ci fa ragionare sulle nostre azioni ed esaminare la nostra coscienza. Non so se avrei avuto il coraggio di Perlasca, non so come avrei reagito e cosa avrei fatto. Forse perché tutto dipende dalle circostanze, dalla situazione, dall’epoca, dalle proprie esperienze, conoscenze ed etica. In fin dei conti non si sa mai cosa potrebbe succedere, a volte possono nascere comportamenti straordinari e spontanei senza neanche ragionarci su, in maniera “banale”e casuale, come nel caso di Perlasca.
1 Gennaio 2019 | Vorrei, quindi scrivo
Il 31 dicembre è un giorno speciale capace di segnare la fine di un anno e la nascita di un altro. Giorno di bilanci e di desideri, giorno che simbolicamente fissa nel calendario un perché per ripensare al passato e per aprirsi al futuro. Insomma, un giorno propizio per essere finestra sul tempo trascorso e sul tempo che deve venire, ma anche per ricordarci dello scorrere del tempo che è stato e che non sarà più. Basti pensare al ruolo che ricopriamo in famiglia di anno in anno: da figli prima a genitori poi, e, un giorno, ancora nonni.
Questa visione del tempo che passa e non torna indietro è comune nella nostra cultura dove il tempo stesso viene definito nemico perché si prende tutto ciò che è più caro fino a segnare e trasformare il nostro corpo di giorno in giorno: le rughe ne sono un piccolo esempio. Non così, invece, era nell’antica cultura greca, dove il tempo veniva definito in due maniere distinte a seconda del suo significato quantitativo, krónos, e qualitativo, kairòs.
Krónos rappresenta il tempo cronologico e sequenziale ed è proprio la mitologia greca a raccontare come questa sola concezione di tempo non sia capace di dare un motivo al vivere di ogni giorno. Infatti, il dio Krónos giungerà a mangiare i propri figli per paura di perdere il potere perché gli era stato predetto che sarebbe stato spodestato da uno di loro. I giorni per Krónos non sono un’opportunità, ma sono segno dell’avvicinarsi della sua fine. E proprio cercando di annientare la realtà dei fatti, ovvero sia nutrendosi dei suoi figli che crescendo gli mostrano l’avvicinarsi della sua fine, Krónos cerca la prova della propria esistenza tentando di rendere eterna la sua condizione attuale di potere. Questa esperienza si ripete quotidianamente ancora oggi in chi ricorre alla chirurgia plastica per eternizzare il proprio viso o a giovani prostitute per proclamare l’eternità della propria virilità, volendo anestetizzare una verità comune a tutti quale il passare irreversibile del tempo.
Poi c’è kairòs che è il tempo come momento opportuno, cioè quel momento anche brevissimo, ma di altissima qualità, capace di dare senso a tutti gli altri istanti precedenti o successivi. E’ l’eternità in un attimo, come il primo bacio con il fidanzatino/a che seppur sia durato solo qualche secondo, sembrava non finire mai e dava una forza incredibile per affrontare ogni cosa, o come l’abbraccio, capace di recuperare il tempo el distacco, con un figlio che ritorna a casa dopo mesi trascorsi all’estero. Ecco come non è più la quantità, ma la qualità del tempo a riempire di gioia e di un motivo per essere felici il vivere quotidiano.
Da un lato il procrastinare di una condizione attuale cercando di saziare una sete egoistica di cui viagra e botulino sono solo due dei tanti strumenti per erigersi al di là del tempo che passa. Dall’altro il cogliere della pienezza del proprio tempo, perché ogni giorno diventa dono per vivere quello che si è in quel preciso momento. Oggi sono figlio, quindi mi faccio voler bene dai miei genitori. Oggi sono padre, quindi mi prendo cura dei miei figli. Oggi sono nonno, quindi vizio i nipoti e lascio consigli ai figli.
L’augurio per questo nuovo anno che verrà è quello di vivere il 2019 come momento opportuno della propria vita per essere la persona che si è, lasciandosi amare da chi ci accoglie per quelli che siamo e abbandonando le pretese di difendere ad ogni costo un’immagine di noi stessi di fronte agli altri o una posizione sociale perché, per quanto la nostra difesa sia imbattibile, il tempo non lascia scampo.
Il primo proposito di questo nuovo anno potrebbe essere individuare quella che è la condizione personale che porta a vedere il tempo solo come krónos, e lasciarla andare per ritornare ad essere liberi a scorgere kairòs, l’eternità del tempo in semplici momenti quotidiani. Perché, a volte, come canterebbe Jovanotti, l’eternità è solo un semplice battito di ciglia.
26 Dicembre 2018 | Vorrei, quindi scrivo
Eterna la roccia, il viso
frustato dal fiato furioso,
ma spinto dal cuore di magma
a scoppi d’oblio rabbioso.
M’ingabbia un abbraccio di nebbia,
mi sento nel buio del vuoto
cometa che d’orbita cieca
ha perso la stella del polo.
Si svela la gemma velata
dai muri di freddo silenzio,
ma spezza il passo del folle
l’attesa del fiore del tempo.
Graffia la terra! Lascia dei segni,
o nulla sarà dopo questa tempesta!
Lascia la guerra! La vita t’insegni
che festa vivrà solamente chi resta!
30 Giugno 2018 | Vorrei, quindi scrivo
Non sono mai stata un’appassionata di letteratura giapponese; non la conoscevo e la conosco poco tuttora, ma quest’anno sto imparando ad apprezzarla. Il mio occhio critico sarà dunque l’occhio di chi si sta avvicinando a questo mondo, e non vuole formulare giudizi perentori e definitivi, bensì fornire una linea di lettura e uno spunto per chi si voglia avventurare nella lettura di testi giapponesi odierni.
Poco tempo fa ho ricevuto un libro di Haruki Murakami, dal titolo L’incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio (2013, edizione italiana 2014). Ho inteso il regalo come una sorta di segno del destino, come se finalmente dovessi provare a dedicarmi a questo tipo di letteratura. Ho iniziato a leggerlo e presto mi sono ritrovata in un universo del tutto nuovo: il mondo giapponese di Murakami è essenzialmente scandito dalla lentezza e dalla tranquillità di ogni gesto. Il protagonista, Tazaki Tsukuru appunto, è molto introspettivo, ragiona per ben sedici anni sulla causa dello smembramento del gruppo di amici perfetto di cui faceva parte ai tempi del liceo a Nagoya. Solo lui, l’incolore (in quanto tutti gli altri membri di quel gruppo, due maschi e due femmine, presentavano il nome di un colore all’interno del proprio cognome) si interroga senza pace sul perché i suoi amici hanno smesso di contattarlo alla fine di un’estate. Quell’allontanamento ha causato in Tazaki Tsukuru un vuoto enorme, e gli ha provocato una depressione profonda e un inevitabile avvicinamento alla morte. Nel romanzo si susseguono anche descrizioni di sogni intensi del protagonista, riguardanti soprattutto le due ragazze del gruppo. Sedici anni dopo, Tazaki decide finalmente di agire e con l’aiuto della sua nuova amica-amante Sara riesce a parlare nuovamente con tre dei quattro amici, giungendo fino in Finlandia e scoprendo in conclusione cos’era successo quella fatidica estate. Il pellegrinaggio del protagonista è sia spaziale sia psichico, ed è necessario dunque per ricercare la verità, oltre che per colmare il desiderio intenso di far pace con un passato che ha modificato completamente l’esistenza di Tazaki. Un passato idilliaco, caratterizzato da quei legami d’amicizia così intensi che capitano forse una sola volta nella vita. La stessa scrittura di Murakami, per quanto concerne questa storia, è volta ad una dimensione tutta mentale e a tratti onirica, con frasi sostanzialmente brevi e cadenzate dall’intensa punteggiatura. Senza dubbio, l’opera porta a riflettere sul valore dell’amicizia e sulle conseguenze devastanti che essa può avere sulla nostra esistenza.
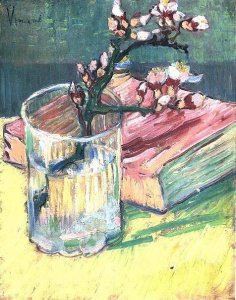
Dopo aver concluso questo libro, ho deciso di proseguire il mio percorso nella letteratura giapponese e dedicarmi invece alla nota scrittrice Banana Yoshimoto: Amrita (1994, edizione italiana 1997) resta uno dei suoi romanzi più celebri, ed anche in questo caso ho avuto il piacere di avventurarmi nel delicato mondo giapponese, osservato però da un punto di vista femminile. Sakumi è una ragazza ventottenne che trascorre una vita pacifica nel ricordo della sorella minore morta in un incidente stradale mentre guidava sotto effetto di alcool e barbiturici. Tuttavia, un giorno Sakumi cade scendendo da una scalinata e batte forte la testa: da qui la sua esistenza cambierà per sempre, in quanto cercherà di recuperare a fatica la memoria persa dopo l’incidente ma nello stesso tempo acquisirà una sensibilità straordinaria, che la porterà ad entrare in contatto con il sovrannaturale (sensibilità che sviluppa anche il suo fratellastro più piccolo, Yoshio, una specie di bambino prodigio). Il romanzo si delinea lungo i viaggi che compie Sakumi in compagnia del suo fratellino e del suo compagno, Ryuichiro; viaggi che le permettono di comprendere ed indagare meglio la sua nuova natura di “morta a metà”, ma nello stesso tempo di “rinata”. È una condizione che le regala una nuova sensibilità verso le persone, i sogni, i ricordi. In effetti, il lettore stesso è portato inevitabilmente a riflettere sui ricordi e sulle immense potenzialità che essi hanno sulla nostra mente. E se, come scrive la stessa Sakumi in una lettera a Ryuichiro, «vivere è dimenticare», questa storia insegna che bisogna tenersi stretti ogni attimo, ringraziare di essere vivi in quel momento, perché ogni istante è diverso dall’altro, ogni tramonto è differente e produrrà sempre una nuova sfumatura di malinconia:
«Mentre il tramonto si allontanava progressivamente, la sensazione di un’indicibile difficoltà a separarsene, e quella rinfrescante della gratitudine si fondevano in modo struggente. Per il resto delle nostre vite, anche se ci fosse stato un altro giorno come questo, mai più la condizione del cielo, la forma delle nuvole, il colore dell’aria, la temperatura del vento si sarebbero ripetuti allo stesso modo».
Con questo intenso passaggio di Amrita concludo ribadendo il mio approccio da principiante riguardo a questi due grandi autori; spero tuttavia di aver invogliato alla lettura dei loro romanzi, opere delicate e semplici, che tuttavia sanno toccare con abilità e senza mai annoiare i temi fondamentali della nostra vita: la morte, la memoria, l’aldilà, l’amicizia, l’amore.
21 Giugno 2018 | Vorrei, quindi scrivo
Ansia. Stress. Tensioni. Nessuno sembra essere completamente al riparo da questi elementi ormai pervasivi della contemporanea “società liquida” descritta dal sociologo Zygmunt Bauman, e che numerosissime ricerche hanno dimostrato essere molto pericolosi per la nostra salute mentale e di conseguenza fisica. La frenesia degli impegni e dei pensieri che affollano la mente ostacola la nostra capacità di vivere il momento presente con consapevolezza, fattore fondamentale per il nostro benessere psicofisico.
Sono molti i possibili rimedi esistenti per far fronte a questo problema. Ho provato a sperimentarne ed approfondirne uno, nato a cavallo tra Oriente ed Occidente: la Mindfulness. Ho partecipato a una lezione di Mindfulness della Dottoressa Laura Falzone, che ha accettato con disponibilità di farsi intervistare per condividere, con chiunque fosse interessato, qualche informazione di base su questa disciplina a mio parere illuminante.
- Saprebbe dirci che cos’è per lei la Mindfulness e come si è avvicinata a questa disciplina?
Per rispondere a questa domanda devo partire da lontano, perché l’incontro con la Mindfulness rappresenta per me la naturale prosecuzione di un percorso di ricerca – parallelo ai miei studi in psicologia e psicoterapia – sulle pratiche di consapevolezza, ovvero di “presenza”, in relazione al corpo. Ho avuto la fortuna di incontrare un’insegnante eccezionale, Lucia Almini, con la quale una decina di anni fa ho intrapreso un cammino individuale di yoga terapia, per circa due anni. Successivamente ho sentito la necessità di proseguire questa ricerca approfondendo ulteriormente le tematiche relative al corpo grazie ad un percorso personale di Analisi Bioenergetica (un approccio psicoterapico centrato prevalentemente sul corpo). L’aspetto centrale di queste due esperienze è stato proprio la riconquista di uno stato particolare, un modo diverso di abitare il corpo, più pieno e consapevole. L’incontro con la Mindfulness è avvenuto in seguito, e in stretta continuità con queste pratiche. Se dovessi dire che cos’è per me la Mindfulness direi essenzialmente presenza e disponibilità: presenza nel corpo, e disponibilità a stare con quello che c’è. Mi sento di dover precisare che i percorsi di Mindfulness che propongo non sono i protocolli tradizionali (es. MBSR), ma sono stati pensati e costruiti in base alla mia esperienza. Accanto alle pratiche di Mindfulness più note utilizzo anche altre pratiche di presenza che ho sperimentato essere preziose.
- Potrebbe darci una definizione della Mindfulness e descrivere le sue pratiche?
La Mindfulness è una disciplina che nasce dall’incontro tra la tradizione buddista theravada e la psicologia occidentale. La definizione più nota della Mindfulness, data da Jon Kabatt-Zinn, è la seguente: “Il processo di prestare attenzione in modo particolare: intenzionalmente, in maniera non giudicante, allo scorrere dell’esperienza, momento per momento”. Si tratta di una definizione preziosa perché nella sua semplicità racchiude tutti gli elementi fondamentali. È questo che essenzialmente si fa nel corso della pratica: si presta attenzione, si osserva. Ma cosa? La nostra esperienza, ciò che accade nel momento presente. E come? In maniera non giudicante, ossia lasciando spazio perché tutto avvenga.
Le varie pratiche ci aiutano ad approfondire l’esperienza, utilizzando vari oggetti su cui portare la nostra attenzione. Ad esempio io posso scegliere di osservare il respiro, oppure posso prestare attenzione ai suoni. Posso scegliere se osservare il flusso dei pensieri, o le emozioni, oppure le sensazioni del corpo, così come il dolore. Talvolta si utilizza anche la visualizzazione, come ad esempio nella meditazione della montagna. L’importante è capire che le pratiche sono una palestra, in cui noi alleniamo il “muscolo della consapevolezza”, per poter poi vivere meglio la nostra vita. I vari strumenti possono inoltre essere adattati per essere utilizzati anche dai bambini: io utilizzo alcune pratiche all’interno di un progetto di prevenzione del bullismo in una scuola primaria.
- Qual è il ruolo giocato dalla respirazione in questa disciplina?
Il ruolo della respirazione è assolutamente centrale. Portare attenzione al respiro, al respiro naturale, e restare nella consapevolezza di questo è il cuore della pratica. Il respiro, così come il battito cardiaco, è una pulsazione vitale. Portare l’attenzione al respiro, e ricondurla ad esso ogni volta che viene catturata da altri elementi, ci riporta al qui ed ora del corpo, al momento presente.
Il respiro può essere considerato come un’àncora, anche nella vita quotidiana. Possiamo tornare all’osservazione del respiro durante il giorno, nel corso di qualsiasi attività, quando i venti dei pensieri incontrollabili e delle emozioni travolgenti diventano troppo forti. Torno al respiro, torno al presente. Questo è il primo passo.
Tra mente e respiro c’è un rapporto strettissimo. In un testo fondamentale dello Yoga – l’“Hatha yoga pradipika” c’è scritto: “Colui che controlla il respiro controlla anche la mente, colui che controlla la mente controlla anche il respiro”.
Anche la psicoterapia occidentale l’ha compreso e utilizza il respiro per la gestione di alcuni stati emotivi. È un tema vastissimo, estremamente interessante, ma credo che il suo approfondimento vada oltre gli scopi di questa intervista.
- Si può applicare la Mindfuness anche nella vita quotidiana, al di fuori delle sedute?
Nel mondo della Mindfulness esistono due famiglie di pratiche: le pratiche formali e le pratiche informali. Le prime sono quelle per le quali occorre ritagliare del tempo. Ad esempio io posso decidere di praticare per venti minuti al giorno l’osservazione del respiro: mi siedo in un luogo silenzioso e mi dedico esclusivamente alla pratica. Ma abbiamo detto prima che la Mindfulness è essenzialmente presenza. Non esiste attività nella mia giornata che io non possa fare con presenza e consapevolezza. Posso scegliere di mangiare, bere il caffè, lavare i piatti, fare la doccia, e farlo in totale piena presenza.
Durante qualsiasi pratica, formale o informale, ci accorgeremo subito che la mente tenderà a vagare, a staccarsi dall’oggetto che avevamo scelto. Non c’è nulla di strano in tutto questo. La nostra mente, tutto il giorno, tutti i giorni, è abituata a vagare, costantemente attratta da moltitudini di oggetti (anche oggetti mentali). Occorrerà riportare indietro l’attenzione numerose volte, senza scoraggiarci o giudicarci severamente. Ogni volta che riusciamo ad accorgerci che la nostra attenzione si è smarrita e la riportiamo sull’oggetto prescelto, siamo già nel cuore della pratica e dovremmo congratularci con noi. L’accettazione e l’assenza di giudizio sono due ingredienti chiave della pratica. Ritornando alla prima domanda. Per me l’incontro con la Mindfulness è stato un dono. Quest’anno ho condiviso questo dono – insieme e grazie a Spazio BioDiversity – con tante persone, riscontrando curiosità ed entusiasmo.
5) Potrebbe salutarci con una frase che riassuma il senso di questa affascinante disciplina?
«Per noi spunta solo quel giorno al cui sorgere siamo svegli» H.D THOREAU
Per quanto mi riguarda, sono arrivata alla lezione di Mindfulness con curiosità, senza sapere cosa avrei trovato. In una sola ora ho potuto sentire la differenza tra una respirazione automatica e distratta e una respirazione più consapevole e allo stesso tempo più spontanea e naturale, “di pancia”, come quella dei bambini. Attraverso esercizi di meditazione e visualizzazione, guidati dalla voce esperta della Dottoressa Falzone, ho provato a sgombrare completamente la mente per concentrarmi solo sul momento presente, rendendomi conto della difficoltà di una procedura così apparentemente semplice. Ho potuto in generale sperimentare il potere rigenerante di uno sguardo che non giudica. Mindfulness per me è serenità, apertura, accettazione. Consiglio a tutti di provare a guardarsi dentro e fuori in modo diverso, con l’aiuto della Mindfulness, per ritrovare la calma e la consapevolezza necessarie per vivere al meglio ogni momento che la vita ci offre.