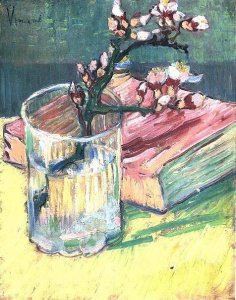23 Dicembre 2018 | Segnalibro
“Da soli” è il titolo dell’ultimo libro di Cristina Comencini (Einaudi, 2018). Scrittrice, ma anche regista e drammaturga, la Comencini racconta questa storia a quattro con assoluta maestria e grande limpidezza. Marta e Andrea, Laura e Piero: due coppie di fidanzati, poi sposi, poi genitori. Due coppie di amici che iniziano la loro storia sul pontile di una nave, quando, ancora venticinquenni, inseguono il futuro e pensano di avere tutta la vita davanti. E poi il matrimonio, e i figli. All’improvviso, quasi in contemporanea, le loro storie finiscono: Marta lascia Andrea, da un giorno all’altro, apparentemente senza motivo; e Piero lascia Laura, dopo una lunga fase di separati in casa.
Il lettore incontra i personaggi proprio qui, nel momento cruciale: quello dei primi mesi di separazione, dopo una vita insieme. In sequenza, la Comencini tesse abilmente la trama dei quattro punti di vista dei protagonisti, ognuno dei quali vive in modo differente questa dolorosa fase. Così, Marta e Andrea, Laura e Piero si trasformano in modelli, prototipi di reazioni possibili dopo una separazione così difficile: Marta è quella che non si sente più libera, che ha bisogno di stare da sola e di cambiare, e quindi lascia Andrea, il modello dell’uomo sentimentale e ancorato ai valori della famiglia. Andrea accetta con difficoltà la decisione inaspettata della moglie, e fatica tremendamente a ricostruire una vita senza di lei, perché in ogni luogo, in ogni momento della vita quotidiana gli torna in mente qualcosa di Marta. Invece, nell’altra coppia è Piero che lascia Laura. Piero è l’incarnazione dell’uomo egocentrico, che non si sente abbastanza amato ma che, allo stesso tempo, tradisce la moglie da anni senza alcun senso di colpa. Laura invece, nonostante sia a conoscenza dei tradimenti di Piero, reagisce malamente alla rottura, in quanto è la tipica donna che ha bisogno costantemente di una persona accanto, con cui condividere ogni aspetto della sua esistenza. Ciascun personaggio, dunque, affronta a modo suo il fantasma, pauroso e incombente, della solitudine in età adulta.
Altre figure ruotano attorno ai quattro, come satelliti: nuovi amanti, figli, amici, che riescono anche a chiarire certe idee ai protagonisti. Tuttavia, il fulcro della vicenda è fissato su diversi temi: il primo e forse più lampante è quello del peso dei ricordi, bellissimo ma lancinante. Per tutti e quattro, ma soprattutto per Andrea e Laura (i “mollati”), i ricordi sono difficilissimi da eliminare dalla mente, perché sono troppo numerosi e troppo intensi. In qualsiasi momento della vita di ogni giorno, possono comparire all’improvviso e distruggere il piccolo nuovo universo che i protagonisti stanno faticosamente costruendo.
Gli altri due temi, sicuramente centrali, sono la famiglia e il matrimonio. L’abilità della Comencini, dando voce alle due coppie, è quella di insinuare un dubbio nel lettore, che come un tarlo lo perseguita per gran parte della lettura: la possibilità, ancora al giorno d’oggi, di credere nell’autenticità del matrimonio e nella possibilità di costruire una famiglia che duri a lungo. Verso metà del romanzo, è il personaggio di Andrea che sembra dissipare ogni incertezza. Lui, marito fedele, comprende che deve mentire ai figli per tranquillizzarli, e dire loro che si è ricostruito una vita accanto ad un’altra donna, di cui è “follemente innamorato”. Arriva a sostenere suo malgrado che, ai giorni nostri, “non c’è niente di più incongruo ed antimoderno che amare una sola persona per tutta la vita”.
“Da soli” è un libro maturo, chiaro e duro nelle sue verità. È anche retrospettivo e poco consolatorio, perché si concentra soprattutto sulla vita oramai passata, e meno verso il futuro. Inoltre, “Da soli” porta inevitabilmente il lettore a riflettere: sui temi elencati prima, e anche sui rapporti umani in generale. Una volta conclusa l’ultima pagina, rimangono in testa alcune martellanti domande, che si pongono gli stessi protagonisti e a cui non si offre una risposta finale: perché la solitudine fa così male? L’essere umano ha davvero bisogno di qualcuno accanto nel corso dell’intera sua vita? E soprattutto: si può amare una sola persona, per sempre?
31 Ottobre 2018 | Segnalibro
L’Italia negli anni Settanta ha vissuto una delle fasi più nere della sua storia: gli anni di piombo costituirono un periodo di aspri scontri politici e di attentati improvvisi tra la gente comune, che generarono un terrore generale e di lunga durata: “non si era mai del tutto felici, anche innamorati, mai veramente lontani, anche nuotando al mare, mai interamente concentrati, anche studiando”. Così ricorda quegli anni Gianni Riotta, che scrive la prefazione di Treno di panna, romanzo d’esordio di Andrea De Carlo. E Treno di panna, uscito nel 1981 (ma già pubblicato in inglese con il titolo di Creamy train), all’epoca sorprese totalmente il pubblico italiano: una storia così diversa, così piena di speranza, così luminosa rispetto al buio di quella che Franco Fortini chiamò “la falsa guerra civile”.
Il romanzo racconta di Giovanni, un giovane italiano venticinquenne che decide di partire per Los Angeles apparentemente per andare a trovare i suoi due amici, Ron e Tracy. In realtà, il ragazzo resta in America e dopo diverse vicissitudini trova lavoro prima come cameriere di un ristorante italiano, fidanzandosi con la cassiera Jill, e poi come insegnante madrelingua in due scuole private della città. Presto la famosa e giovane attrice Marsha Mellows diventa una sua allieva, e Giovanni se ne innamora follemente. È proprio la passione per la sua studentessa che scuote finalmente il protagonista da quel torpore che il lettore percepisce fin dall’inizio della vicenda: Giovanni infatti si limita a fare il minimo indispensabile per sopravvivere in città, vivendo come ospite prima a casa dei due amici e poi a casa di Jill e cercando lavori di fortuna tramite curricula inventati.
Per di più, il ragazzo sembra osservare la realtà di Los Angeles dall’esterno, senza viverci veramente dentro: tramite i suoi occhi, il lettore vede una città brulicante e piena di aspettative verso il futuro, affamata di successo e notorietà. Lo stesso De Carlo ha trascorso un certo periodo della sua vita a Los Angeles insegnando italiano, proprio come Giovanni, e ciò gli ha permesso senza dubbio di tracciare un quadro dettagliato della metropoli. Accanto allo sguardo disincantato del ragazzo emerge paradossalmente e allo stesso tempo uno sguardo minuzioso: infatti il protagonista ha la passione per la fotografia, e girovaga per Los Angeles fotografando dettagli apparentemente insignificanti: “il dettaglio di un’automobile, il particolare di un abito, il frammento di un gesto frettoloso”. Si tratta dello stesso occhio del primo De Carlo, che Calvino aveva precocemente notato, parlando della sua “acutezza dello sguardo”.
Come l’incipit della storia, il finale descrive un panorama notturno di Los Angeles, un turbinio di luci nel “lago nero” della notte. È un finale aperto, denso di possibilità future: si legge tra le righe il brivido positivo e tutto giovanile dell’incertezza del futuro.
Ci si potrebbe giustamente domandare: perché Treno di panna? Che relazione ha il titolo del romanzo con tutta la vicenda? Si tratta del titolo inventato del film che Marsha Mellows aveva girato a Venezia nel 1971, durante il quale aveva conosciuto il suo attuale marito, l’attore Arnold Bocks. Il film lega allora Giovanni con Marsha per diversi motivi: l’attrice utilizza un quadernetto per le lezioni di italiano che aveva comprato proprio durante quel viaggio in Italia, ma non solo. Dice ad un certo punto il protagonista: “la vera cosa strana era che Treno di panna era il primo film di Marsha Mellows che avevo visto in vita mia. A pensarci mi riusciva abbastanza difficile respirare”. Nel libro non si esplicita mai veramente la vicenda che veniva raccontata nel film, ma metaforicamente si potrebbe pensare che “treno di panna” stia ad indicare proprio l’atteggiamento generale della città di Los Angeles: la determinazione e la speranza paragonate ad un solido treno che corre veloce, in una dimensione tuttavia sempre sognante, dolce come la panna. E proprio questo approccio alla vita, che alla fine viene adoperato anche dal protagonista, influenzò enormemente i letterati italiani di quegli anni, tanto che Gianni Riotta scrive: “era il mondo della nostra maturità, il futuro. Salimmo sul treno di panna, guardammo il tramonto della guerra fredda e lo sbriciolarsi dei suoi muri assassini e diventammo adulti”.
30 Giugno 2018 | Vorrei, quindi scrivo
Non sono mai stata un’appassionata di letteratura giapponese; non la conoscevo e la conosco poco tuttora, ma quest’anno sto imparando ad apprezzarla. Il mio occhio critico sarà dunque l’occhio di chi si sta avvicinando a questo mondo, e non vuole formulare giudizi perentori e definitivi, bensì fornire una linea di lettura e uno spunto per chi si voglia avventurare nella lettura di testi giapponesi odierni.
Poco tempo fa ho ricevuto un libro di Haruki Murakami, dal titolo L’incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio (2013, edizione italiana 2014). Ho inteso il regalo come una sorta di segno del destino, come se finalmente dovessi provare a dedicarmi a questo tipo di letteratura. Ho iniziato a leggerlo e presto mi sono ritrovata in un universo del tutto nuovo: il mondo giapponese di Murakami è essenzialmente scandito dalla lentezza e dalla tranquillità di ogni gesto. Il protagonista, Tazaki Tsukuru appunto, è molto introspettivo, ragiona per ben sedici anni sulla causa dello smembramento del gruppo di amici perfetto di cui faceva parte ai tempi del liceo a Nagoya. Solo lui, l’incolore (in quanto tutti gli altri membri di quel gruppo, due maschi e due femmine, presentavano il nome di un colore all’interno del proprio cognome) si interroga senza pace sul perché i suoi amici hanno smesso di contattarlo alla fine di un’estate. Quell’allontanamento ha causato in Tazaki Tsukuru un vuoto enorme, e gli ha provocato una depressione profonda e un inevitabile avvicinamento alla morte. Nel romanzo si susseguono anche descrizioni di sogni intensi del protagonista, riguardanti soprattutto le due ragazze del gruppo. Sedici anni dopo, Tazaki decide finalmente di agire e con l’aiuto della sua nuova amica-amante Sara riesce a parlare nuovamente con tre dei quattro amici, giungendo fino in Finlandia e scoprendo in conclusione cos’era successo quella fatidica estate. Il pellegrinaggio del protagonista è sia spaziale sia psichico, ed è necessario dunque per ricercare la verità, oltre che per colmare il desiderio intenso di far pace con un passato che ha modificato completamente l’esistenza di Tazaki. Un passato idilliaco, caratterizzato da quei legami d’amicizia così intensi che capitano forse una sola volta nella vita. La stessa scrittura di Murakami, per quanto concerne questa storia, è volta ad una dimensione tutta mentale e a tratti onirica, con frasi sostanzialmente brevi e cadenzate dall’intensa punteggiatura. Senza dubbio, l’opera porta a riflettere sul valore dell’amicizia e sulle conseguenze devastanti che essa può avere sulla nostra esistenza.
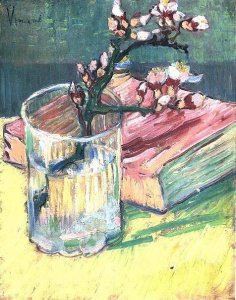
Dopo aver concluso questo libro, ho deciso di proseguire il mio percorso nella letteratura giapponese e dedicarmi invece alla nota scrittrice Banana Yoshimoto: Amrita (1994, edizione italiana 1997) resta uno dei suoi romanzi più celebri, ed anche in questo caso ho avuto il piacere di avventurarmi nel delicato mondo giapponese, osservato però da un punto di vista femminile. Sakumi è una ragazza ventottenne che trascorre una vita pacifica nel ricordo della sorella minore morta in un incidente stradale mentre guidava sotto effetto di alcool e barbiturici. Tuttavia, un giorno Sakumi cade scendendo da una scalinata e batte forte la testa: da qui la sua esistenza cambierà per sempre, in quanto cercherà di recuperare a fatica la memoria persa dopo l’incidente ma nello stesso tempo acquisirà una sensibilità straordinaria, che la porterà ad entrare in contatto con il sovrannaturale (sensibilità che sviluppa anche il suo fratellastro più piccolo, Yoshio, una specie di bambino prodigio). Il romanzo si delinea lungo i viaggi che compie Sakumi in compagnia del suo fratellino e del suo compagno, Ryuichiro; viaggi che le permettono di comprendere ed indagare meglio la sua nuova natura di “morta a metà”, ma nello stesso tempo di “rinata”. È una condizione che le regala una nuova sensibilità verso le persone, i sogni, i ricordi. In effetti, il lettore stesso è portato inevitabilmente a riflettere sui ricordi e sulle immense potenzialità che essi hanno sulla nostra mente. E se, come scrive la stessa Sakumi in una lettera a Ryuichiro, «vivere è dimenticare», questa storia insegna che bisogna tenersi stretti ogni attimo, ringraziare di essere vivi in quel momento, perché ogni istante è diverso dall’altro, ogni tramonto è differente e produrrà sempre una nuova sfumatura di malinconia:
«Mentre il tramonto si allontanava progressivamente, la sensazione di un’indicibile difficoltà a separarsene, e quella rinfrescante della gratitudine si fondevano in modo struggente. Per il resto delle nostre vite, anche se ci fosse stato un altro giorno come questo, mai più la condizione del cielo, la forma delle nuvole, il colore dell’aria, la temperatura del vento si sarebbero ripetuti allo stesso modo».
Con questo intenso passaggio di Amrita concludo ribadendo il mio approccio da principiante riguardo a questi due grandi autori; spero tuttavia di aver invogliato alla lettura dei loro romanzi, opere delicate e semplici, che tuttavia sanno toccare con abilità e senza mai annoiare i temi fondamentali della nostra vita: la morte, la memoria, l’aldilà, l’amicizia, l’amore.